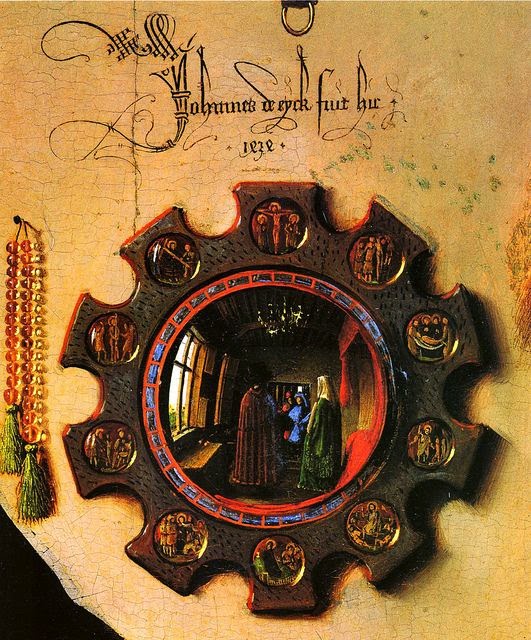Il
mio e il nostro futuro
Pensieri
sull’arte e sul suo imprevedibile destino
“La guerra è il sistema
più spiccio per trasmettere una cultura.”
Anthony Burgess
Quasi settant’anni senza conoscere da vicino la
sofferenza di una guerra. Ci siamo così talmente abituati, che non facciamo più
caso a questa particolarità e per molti di noi è un avvenimento che riguarda
soltanto qualcuno di molto distante, nel tempo e nello spazio. I nostri padri,
che soffrirono prima l’infamia della dittatura e poi i patimenti delle
distruzioni, dell’indigenza e della fame, alla fine di tutto ciò sembra che
abbiano lasciato in eredità soltanto qualcosa di invisibile e impalpabile,
difficilmente percettibile in assenza di un pensiero determinato, profondo e
ragionato.
Da sempre, tutte le guerre e le relative conquiste
territoriali hanno portato, insieme alla distruzione, un cambiamento radicale
nella vita delle nazioni interessate coinvolgendone tutti gli aspetti:
economico, sociale, militare, tecnologico e culturale. Questi ultimi due
aspetti, per secoli sicuramente i meno rilevanti per la vita giornaliera delle
persone e per il loro benessere primario, sono quelli che negli ultimi cento
anni hanno particolarmente influenzato il nostro comportamento, molto più che
nei tempi passati. La tecnologia, con la sua esplosione e rapida espansione, ha
permesso la diffusione globale di un patrimonio culturale che, fino a pochi
decenni fa, era egemonia di pochi fortunati. La diffusione della radio, dei mezzi
di riproduzione audio e video sempre più perfezionati e per ultimo di internet,
sono forse assimilabili come importanza soltanto al progresso della stampa dopo
Gutenberg.
In passato, le guerre e le conquiste territoriali erano
perpetrate per i motivi da tutti conosciuti. Si trattasse di espansionismo
psicotico delirante o di uno scopo puramente economico, dopo di esse i popoli
sconfitti vedevano modificare profondamente la loro particolare natura,
uscendone a volte completamente distrutti e inabili a riprendersi e a volte
rinvigoriti a seguito dell’annessione a popoli culturalmente affini o
superiori. Dal 1945 a oggi, il mondo occidentale non ha più conosciuto guerre
intestine devastanti. La macelleria della prima guerra mondiale e la
devastazione a tappeto della seconda, sembrano lontani ricordi sopravvissuti
soltanto in qualche memoria scritta o relegati in qualche reperto
cinematografico d’epoca. Le guerre, da allora, l’occidente le ha vissute
altrove: in Corea, in Vietnam, in Afghanistan, in Iraq e da esse, nonostante
alcune sonore sconfitte, è riuscito talvolta a trarne vantaggi economici. La
storia insegna che dopo la sconfitta del nemico, qualsiasi esso sia, avviene
una metamorfosi nel DNA della nazione interessata. Il patrimonio culturale di
essa, profondamente colpito, difficilmente tende a rinnovarsi esattamente come
era prima. La contaminazione apportata dai nuovi conquistatori, anche quando
per molti versi può apparire positiva, inevitabilmente tende a causare un
depauperamento dei valori precedentemente custoditi da quella particolare
società o nazione sostituendoli con altri, spesso contrastanti se non
addirittura completamente differenti. A volte, triste destino, questo
cambiamento risulta decisivo per un nuovo e dinamico sviluppo della società. Il
processo di cambiamento/sostituzione, che una volta richiedeva alcuni ricambi
generazionali, nel dopoguerra è avvenuto molto più velocemente che in passato,
senza lasciare il tempo biologico di “digerire” l’avvenimento storico in sé. In
tutto il mondo, nonostante i profondi cambiamenti politici e sociali avvenuti,
per primo la rivoluzione del ’68 e poi la fine della Guerra Fredda con caduta
del Muro di Berlino, abbiamo assistito poco a poco ad una sorta di omologazione
culturale inevitabilmente causata dall’avvento tecnologico e che ha coinvolto i
molteplici aspetti della vita quotidiana. La diffusione delle comunicazioni di
massa e la facilità di spostamenti, hanno contribuito in modo sostanziale allo
scambio di idee, costumi e comportamenti abituali. La stessa alimentazione,
varia, ricca e sovrabbondante rispetto al passato, ha avuto un ruolo
determinante nella diffusione degli scambi culturali. Ovunque oggi, è possibile
pranzare italiano o cinese al mattino e indiano o turco alla sera. Possiamo
cenare a Parigi e pranzare a Tokyo con una facilità impensabile soltanto fino a
pochi anni fa. Allo stesso modo, accendendo la tv satellitare, possiamo
assistere in diretta ad un concerto dei Berliner Philharmoniker e poco dopo a
uno spettacolo Kabuki, magari interrompendolo per rispondere a una telefonata,
per poi riprenderlo già registrato. La diffusione del PC e del web ha siglato,
per ora e in modo indelebile, i nostri comportamenti abituali. In poco più di
dieci anni ci siamo completamente trasformati senza rendercene conto, azzerando
i concetti di tempo e spazio, ribaltando
e trasformando la loro natura analogica inevitabilmente legata alla percezione
umana e poi quella metafisica, già in parte azzerata secoli fa dall’avvento
della misurazione del tempo pervenuto alla portata di tutti e dall’avvento
della stampa e della cartografia. Una volta esistevano i custodi del tempo coi
loro campanili e quelli dello spazio con le loro biblioteche e carte geografiche.
Oggi, i custodi di questo patrimonio siamo tutti noi, o se non altro, pensiamo
di esserlo.
“Imparare
è un'esperienza; tutto il resto è solo informazione.”
Albert
Einstein
La singolarità nella quale più o meno inconsciamente
stiamo vivendo, non ci permette di dedicare particolare attenzione alla natura
e alla qualità di tutto ciò che, in tempo reale, desta la nostra attenzione e
ne favorisce la fruizione quotidiana. Siamo tutti assuefatti a comportamenti dati
per scontati e che consideriamo siano destinati a durare in eterno. La
diffusione generalizzata dello scibile umano, da quello più banale a quello più
elitario, che coinvolge arti, scienze e mestieri, ha favorito la nascita di un
immenso oceano, un contenitore alla portata di chiunque dove è apparentemente
facile navigare, ma altrettanto facile perire fra i suoi flutti. All’uomo
comune è stata concessa una patente nautica per essere al comando di un
transatlantico, ma non ci si è resi
conto che per ora è in grado di condurre, sì e no, una barca a remi. E’ un po’
la storia del gatto che, specchiandosi, si ammira leone. Di fronte allo schermo
del nostro PC, il più potente simbolo odierno del raggiungimento tecnologico, tutti
noi ci sentiamo un po’ leoni, ma siamo pronti a ricrederci nell’istante in cui
ci rendiamo conto di essere soltanto dei topolini in presenza di un gatto
famelico.
Tutte le attività che per loro natura tendono a
coinvolgere la parte più razionale dell’uomo, necessitano da sempre di un
approccio decisamente più scientifico. Se è immaginabile un’iniziale scienza
intuitiva in quanto assioma, non è assolutamente immaginabile una scienza
improvvisata nel momento in cui si trasforma in postulato. Occorrono conoscenze
precedenti che non possono lasciare dubbi o incertezze di sorta. Ciò non è
indispensabile per altre attività umane, o meglio, da poco tempo non è più
necessario. In campo artistico, ad esempio, azzerate le barriere stilistiche
nelle arti figurative, nella letteratura e nella musica, l’espressione è
diventata, “democraticamente”, patrimonio di tutti. Tutti dipingono, tutti
scrivono, tutti suonano uno strumento, tutti compongono. E’ chiaro che in una
situazione così disorganica, solo pochi personaggi veramente geniali e in grado
di distaccarsi dalla limitatezza generale sono in grado di “inventare” e di
conseguenza emergere per essere ricordati, anziché, nel caso più fortunato,
essere relegati in un’enciclopedia. La particolarità del nostro momento
storico, in cui la libertà d’espressione è per tutti noi sacrosanta e che non
concepiamo altrimenti, fa sì che tutte le nostre attività, dalle più elitarie
alle più accessibili, si uniscano in un immenso calderone dove è pressoché
impossibile distinguere il vero dal falso, il genuino dall’artefatto, l’obiettivo
dall’inattendibile. E’ una situazione paradossale perché, se da un lato concede
la possibilità di esprimerci secondo ciò che ci è connaturato ma negandoci la
visibilità, dall’altro, concedendoci apparentemente l’accesso a una miriade di
informazioni, ci impedisce di padroneggiare una libera e vera conoscenza. Sul
piano strettamente critico, in mancanza di definizioni, paletti, barriere, siamo
quasi incapaci di valutare il nostro operato finale perché non è più soggetto a
modelli culturali ben definiti. E’ una situazione antropologica anomala,
decisamente atipica e sconosciuta nei tempi passati, quando le regole imposte
dalla società dettavano i limiti entro i quali l’espressione personale poteva
aver luogo, seguendone mode, costumi, vizi e consuetudini. Un mondo sicuramente
più sicuro e blindato, talvolta ingegnosamente contaminato da lontano e
incrinato da personaggi geniali, gli unici meritevoli di emergere e gli unici,
spessissimo, condannati per la loro diversità rispetto allo “status quo”.
E’ chiaro che per l’uomo normale, in questo contesto
risulta difficilissimo, se non addirittura impossibile, formulare personali
criteri di valutazione adeguati e indipendenti senza ricorrere per forza a condizionamenti
esterni. A meno che non sia in possesso di conoscenze specifiche in un
particolare campo, comunque limitate all’educazione estetica ricevuta e non sia
in possesso di una particolare autonomia di giudizio, difficilmente potrà farsi
un’idea convinta di un’opera dell’ingegno o di un’opera d’arte. Nel caso
dell’opera d’arte, sempre che tale sia, sarà ancora più difficile, in assenza
di quei confini convenzionali che un linguaggio, per essere tale, necessariamente
richiede. Nel “mare magnum” in cui le arti da tempo si trovano, è divenuto difficile
affidarsi ai medesimi criteri di valutazione del passato. Non che sia
impossibile, è soltanto, concretamente, inutile. E’ inutile perché qualsiasi
valutazione affidata a canoni estetici riferiti a modelli culturali precedenti,
inevitabilmente deve fare i conti con lo sterminato e differenziato mondo
attuale, senza più confini, eccettuati quelli geografici, e destinato ad
ampliarsi sempre più in virtù dello sviluppo tecnologico che avanza
inesorabile. I rischi della situazione in atto sono sotto gli occhi di tutti.
L’azzeramento dei confini culturali, l’omologazione forzata verso un pensiero
unico, quello dettato dalla tecnologia, l’appiattimento verso comportamenti
forzosamente e sapientemente pilotati e la difficoltà di discernimento da parte
delle generazioni più giovani, inducono a pensare che in breve tempo possa avvenire
una sorta di lobotomia totale delle coscienze, col conseguente cambiamento
radicale della personalità degli individui e delle loro esigenze.

“Si
usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per
guardare la propria anima.”
George
Bernard Shaw
La possibilità odierna di potersi confrontare con un
universo di opportunità, sensazioni e godimenti infinito; il potersi esprimere
in modo inadeguato e disordinato, inutile e a volte controproducente al nostro
essere; l’avere a disposizione una bengodi di risorse illimitate accompagnata però
da una sorta di torpore ipertrofico dell’intelletto, spinto a ricevere in modo
acritico quantità enormi di sollecitazioni, potrebbe far sì che il nostro
cervello, talmente pressato da eccitamenti di ogni genere, potrebbe non essere
più in grado di esprimersi naturalmente e, anziché svilupparsi armoniosamente
nei tempi e modi dettati dalla nostra umana natura bisognosa di consolidarsi
nel tempo, potrebbe congestionarsi fino al punto di non recepirne più alcun
beneficio. E’ in gioco la struttura analogica del nostro modo di pensare che
rischia di subire un corto circuito a causa del sovraccarico di stimoli. Le
premesse per questo accadimento ci sono tutte e i primi segnali d’allarme di questa
aberrante situazione sono stati ormai percepiti. Senza un mirato intervento finalizzato
al cambiamento radicale e concreto della società, potremmo assistere alla fine dei
comportamenti analogici dell’uomo, a iniziare da una delle sue vitali
manifestazioni: l’espressione artistica nelle sue molteplici forme e linguaggi.
Di sicuro, parte dell’arte come è comunemente intesa,
cioè una necessità d’espressione individuale, raramente collettiva, da tempo ha
iniziato a modificarsi. In certe circostanze si è trasformata in una
manifestazione sprovvista di un’anima idonea a farle da motore. Che riguardi la
letteratura, l’arte figurativa o musicale, si è convertita in denuncia, in
provocazione pubblica, in dissacrazione determinata. La differenza col passato
non sta nel merito del messaggio, peraltro gloriosamente già perpetrato da
grandi geni, bensì nel suo più intrinseco valore: la mancanza di quella parte
“soprasensibile” che ne fa oggetto e non più soggetto. In assenza di quella
parte “soprasensibile, trascendentale, mistica, sublimata”, definiamola come ci
pare, l’arte diventa altra cosa. Le collettività non hanno mai dimostrato di
riuscire a esprimersi armoniosamente e al massimo grado senza ricorrere a un
ideale. Quando lo hanno fatto, si sono presto trasformate in brutali strumenti
atti a rivoluzionare una particolare situazione, dimostrando però di non essere
in grado di gestire circostanze più complesse. E’ in quel momento di
instabilità che i popoli necessitano di un cambiamento radicale della loro vita
che ne modifichi le esigenze, li induca ai doveri dimenticati e che ne riorganizzi
la struttura sociale. In passato, il capo “di turno”, generalmente un individuo
mediocre, era sempre pronto a raccoglierne l’istanza e, nonostante fosse
animato da oneste intenzioni, commetteva prima o poi errori irreparabili. La
storia insegna che dopo il periodo di consenso, inevitabilmente sopraggiungeva
la sua caduta e con essa il disastro della guerra che, come si sa, faceva
piazza pulita di tutto e di tutti. Dopo di essa, come dicevo all’inizio, ai
popoli erano riservate due possibilità: l’annichilimento o la rinascita. Oggi
le guerre sanguinarie non le vuole più nessuno. Troppi costi umani, troppi
imprevisti, troppa visibilità. Per rimodellare un popolo, una nazione o una
zona geografica è sufficiente una guerra tecnologica adatta a manovrare i mezzi
di comunicazione. Ha l’effetto di “rimodellare” le coscienze attraverso l’induzione
verso nuovi comportamenti; silenziosamente può spingerci alla predilezione per
questo o quel prodotto culturale oppure costringerci ad atteggiamenti inadatti
e pericolosi. In pratica, può condizionare il nostro comportamento
muovendoci verso scelte positive o
negative, per noi stessi e per la società. La “realtà virtuale” nella quale
siamo immersi, ha già la possibilità di farci credere qualsiasi cosa: dall’arrivo
dei marziani in Patagonia allo scoppio di una inesistente epidemia in Canada,
al crollo fittizio delle borse in Oriente.
Prima o poi, è inevitabile, giungerà il momento in cui,
con determinazione, si dovrà provvedere a cambiare la situazione dal profondo.
Si tratta della sopravvivenza dell’uomo secondo la sua primaria natura programmandone
il suo ri-dimensionamento, pena la sua estinzione; cancellarne l’eresia
antropocentrica, pensando a un ritorno alla semplicità che potrebbe garantirgli
visioni straordinarie. Paradossalmente, proprio grazie a questa tecnologia, in
questo momento apparentemente devastante, si potrebbe essere pronti a ricondurlo
nuovamente alla sua origine, evitando una situazione di stallo per l'umanità e
scongiurando il giorno nel quale probabilmente potrebbe essere troppo tardi per
trovare qualsiasi soluzione.
“La
persona, in generale, significa una sostanza individua di natura ragionevole.
L’individuo poi, è ciò che è indistinto in se stesso e distinto dagli altri.
Perciò la persona, in qualsiasi natura, significa ciò che è distinto in quella
natura, così nella natura umana significa questa carne, queste ossa,
quest’anima, che sono principio di individuazione per l’uomo; le quali cose pur
non facendo parte del significato di persona, tuttavia fanno parte di quello di
persona umana”
Tommaso
d’Aquino